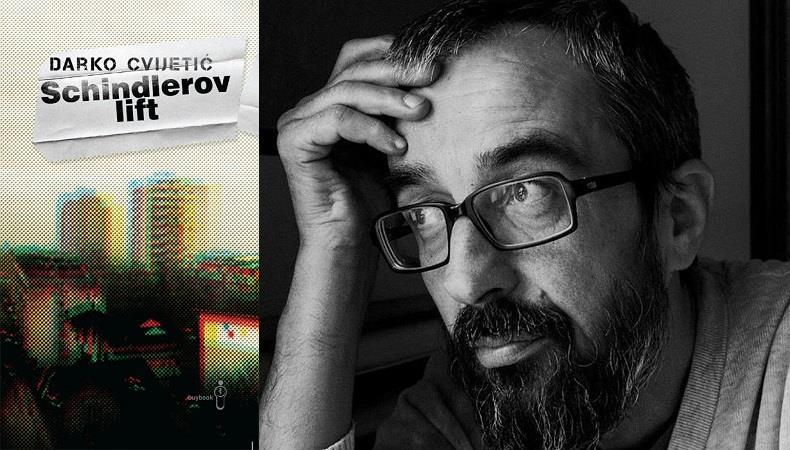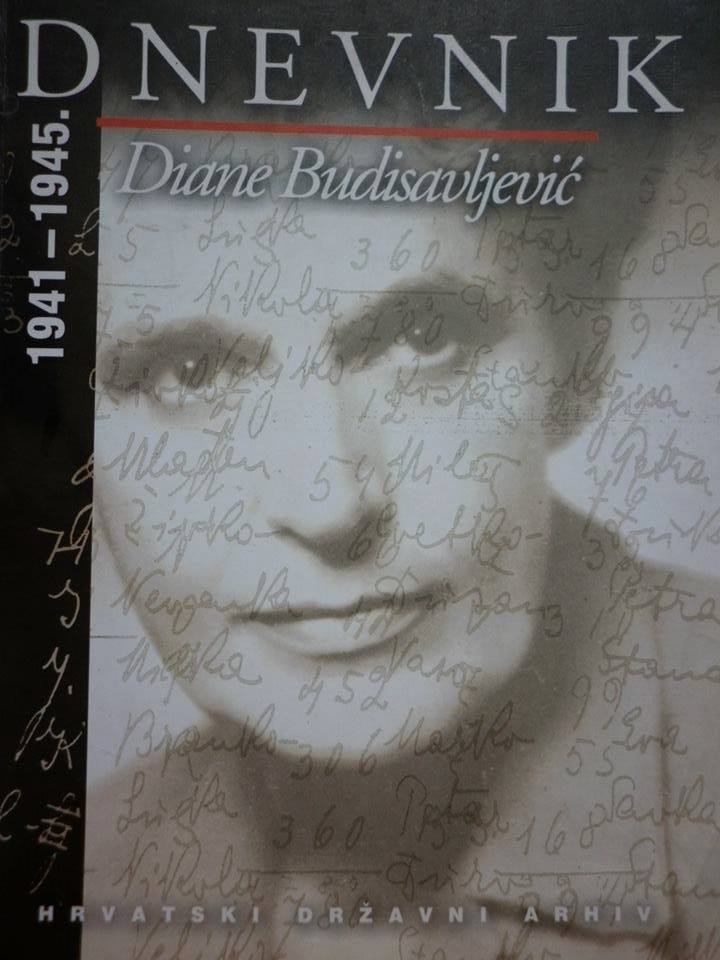Edvard Cucek ricorda la tragedia di Srebrenica, nel 25° anniversario, in un articolo già apparso su atlanteguerre.it (clicca QUI per leggere l’originale).

L’11 luglio il mondo ricorda i 25 anni dal genocidio di Srebrenica. Per alcuni genocidio, per altri uno sterminio di massa, per alcuni addirittura un fatto mai accaduto. In realtà, i due termini, di cui il primo è molto più grave di secondo, non cambiano minimamente le circostanze nelle quali accadde il tutto e nemmeno il numero delle vittime. L’episodio è avvenuto nella zona protetta dalle Nazioni Unite e dai loro caschi blu. Come negli anni precedenti a Srebrenica si riverseranno le solite più o meno 20mila persone. L’umanità si recherà in quel luogo per ricordare un episodio di cui naturalmente dovrebbe vergognarsi. Quella cittadina, fondata sulla antica Argentium romana dai minatori sassoni arrivati in Bosnia nel quattordicesimo secolo al seguito degli inviti dei Re bosniaci Stjepan Kotromanić e Tvrtko è diventata nel tempo importante per l’intero regno e per le aree circostanti grazie ai commercianti ragusei (della Dubrovnik odierna). Proprio lì infatti fondarono la loro colonia, rimasta attiva fino alla caduta del regno bosniaco sotto gli Ottomani.
Quest’anno dovrebbero essere seppelliti altri 11 resti umani identificati portando il numero finale delle lapidi da 6482 del 2019 a 6493. Altri 37 resti sono in attesa dell’autorizzazione dei famigliari nel “Centro di identificazione Podrinje”. Ne restano ancora altri 99 da identificare nel “Centro commemorativo a Tuzla”. E poi…?
Il giorno 11 luglio 2020 durerà le sue 24 ore. I venditori delle magliette con su scritto il numero delle vittime, disgustosa idea commerciale da proibire, faranno gli affari. Si venderanno le tonnellate di ćevapi e altri cibi del tradizionale “street food bosniaco” per sfamare le migliaia di pellegrini e curiosi che verranno a Srebrenica per la prima volta. La vita tornerà quella che conoscono bene gli abitanti di una volta ricca e nel mondo conosciuta Srebrenica. Conosciuta molto prima che si sapesse di Zagabria con quel nome, prima che la Sarajevo di oggi fosse fondata. Si tornerà alla vita che interessa poco ai politici e tanti altri che si presentano lì solo in quel giorno per essere visti. Loro ed il “loro dolore”.
Non saranno loro, nonostante l’ennesima promessa, a fare qualcosa per cambiare la vita dei sopravvissuti, rientrati, vivi e propensi a crescere lì i loro figli, se solo potessero contare su un briciolo di sostegno. In quella giornata verranno pronunciate le banalità di sempre, confezionate a seconda dei tempi che corrono e dette “solennemente” da qualche nuovo funzionario politico, di solito bosgnacco (musulmano) e possibilmente unitarista, con le promesse di un futuro se non d’oro allora almeno d’argento per i suoi connazionali sofferenti.
Pochi penseranno di offrire qualche posto di lavoro, di costruire qualche asilo nido, scuole, di ripristinare le strade, gli acquedotti, la rete elettrica e rendere la vita ai “sopravvissuti” dignitosa e sopportabile.
In quella stessa giornata, oltre il fiume Drina, come ogni anno, i negazionisti e le autorità della vicina Serbia, sempre solidali con i fratelli serbo bosniaci, suonando su tutte le campane inviteranno il mondo a riflettere e respingere una volta per sempre “tutta questa messa in scena” con i numeri gonfiati e falsi. Nonostante tutti gli scenari ormai standardizzati nel corso degli anni, la differenza tra i 36.666 abitanti di Srebrenica come da censimento del 1991 e quei 13.409 del censimento del 2013, ovvero 23 257 anime in meno, alle quali vanno aggiunti quelli perennemente disoccupati che nel frattempo hanno dovuto andar via oppure sono tornati solo “sulla carta”, non sarà ridotta di una cifra.
La giornata di vero dolore di coloro che vengono a piangere i propri cari e a cui la vita è stata stravolta per sempre, ma anche quella d’occasione per i vari opportunisti della politica attuale in cerca di visibilità, sarà il giorno successivo rimpiazzata dalla grigia quotidianità di coloro che oramai raramente pronunciano la parola speranza.
Tutti gli occhi che guardano Srebrenica anche in novembre quando è piena di fango o in gennaio, quando il manto della neve bosniaca copre completamente le lapidi e le disastrose strade cittadine in modo da rendere il tutto armonioso, resteranno da soli fino al prossimo 11 luglio. A riflettori e microfoni spenti. Andrà avanti così. Fino al giorno, se il trend dovesse continuare, in cui in un luglio fra vent’anni gli unici abitanti con residenza fissa, in quella cittadina con una storia ricca e sofferta, saranno solo le vittime sepolte nel memoriale di Potočari. Soltanto perché da lì, da sole, non potranno mai andare da nessun’altra parte.