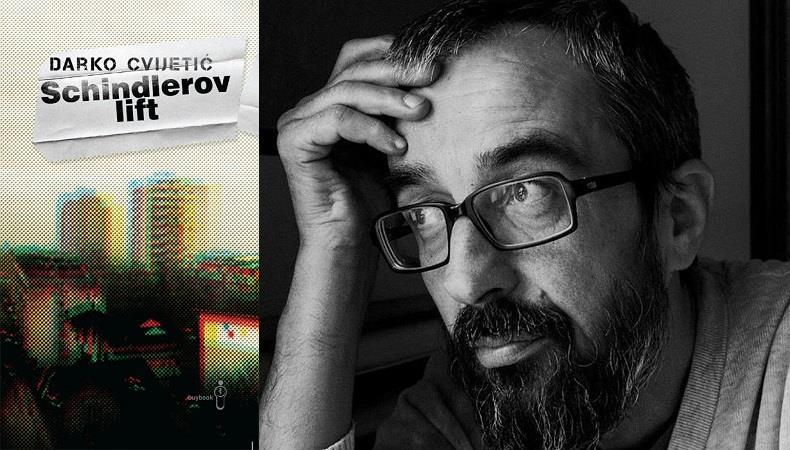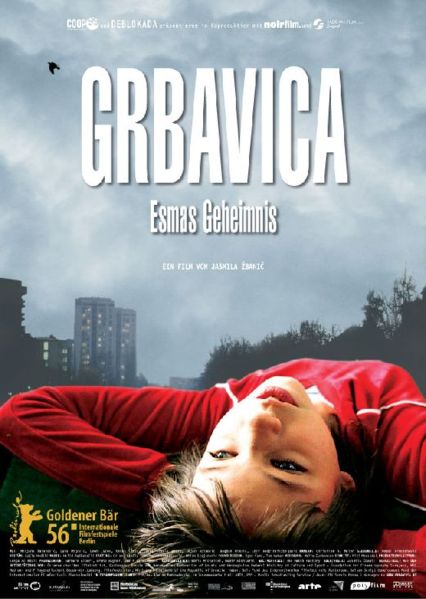IL VICESINDACO DI PRIJEDOR HA INCONTRATO LA DELEGAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE PROGETTO PRIJEDOR DI TRENTO
Il vicesindaco di Prijedor, Žarko Kovačević, ha tenuto oggi un incontro con la delegazione dell’Associazione “Progetto Prijedor” di Trento, guidata da Ezio Pilati, Presidente dell’Associazione.
L’argomento dell’incontro era il progetto triennale, che viene attuato tra la Città di Prijedor e l’Associazione Progetto Prijedor. L’obiettivo del progetto è favorire lo sviluppo locale attraverso il microcredito e il sostegno alle piccole e micro imprese. Il progetto si articola in tre fasi, di cui due sono completate. L’incontro ha discusso le possibilità e le modalità di attuazione della terza fase, che includerebbe l’apertura di un Centro o punto per sostenere lo sviluppo dell’imprenditorialità e dei microimprenditori, nonché la sua ubicazione e sostenibilità. Nel corso dell’incontro è stata espressa la volontà di proseguire il dialogo e la collaborazione tra l’Associazione e l’Amministrazione comunale di Prijedor, che negli anni si è rivelata molto proficua.
A PRIJEDOR INNAUGURATO L’OTTAVO MURALE CHE SI INTITOLA “IL CIELO E’ IL CONFINE” DELL’AUTORE DRAGAN INDJIC.
La città di Prijedor da oggi ha l’ottavo murale, che si intitola “Il Cielo è il confine”. Questo murale, dipinto dal pittore e grafico academico, Dragan Indjic, ora decora la facciata esterna della Scuola economica e alberghiera di Prijedor.
Attraverso questo murale l’autore invia il messaggio che non ci sono limiti nello sviluppo personale.
– Come ex studente della Scuola economica, volevo dire in qualche modo che l’istruzione formale non deve essere la fine, che gli studenti possono sempre migliorare e imparare in altre direzioni – ha detto Indjić.
Il presidente dell’Associazione degli artisti di Prijedor, Boris Eremić, afferma che quest’anno sono state presentate 18 opere provenienti da Portogallo, Germania, Spagna, Italia, Bosnia ed Erzegovina e Serbia.
– Per quanto ne so, questo progetto è l’unico del suo genere nell’Europa sudorientale, ed è motivo di orgoglio sia per noi che per la città di Prijedor, e l’importante è che l’interesse non stia diminuendo – ha sottolineato Eremić.
Il vicesindaco di Prijedor, Zarko Kovacevic, afferma che il governo locale continuerà a sostenere l’arte e questo progetto.
– Prijedor è una città di murales, pittori, artisti, qui l’Amministrazione Comunale ha sostenuto finanziariamente questa storia e questo murale. Sono particolarmente contento che il murale si trovi in una scuola pubblica e che proprio un cittadino e artista di Prijedor abbia dipinto questo murale – ha concluso Kovačević.
L’obiettivo di questo progetto è quello di marcare Prijedor come una città di pittori e di renderla riconoscibile attraverso murales nella regione più ampia e sulla mappa culturale d’Europa, sottolinea l’Associazione degli Artisti di Prijedor.
– Abbiamo davanti a noi l’ottavo murale di Prijedor che si realizza interno al progetto “Prijedor – città dei murales” che promuove l’Associazione Artisti di Prijedor in collaborazione con la città di Prijedor e i nostri amici dell’Associazione Progetto Prijedor e della comunità trentina, che hanno sostenuto questa storia dal primo momento – ha aggiunto Boris Eremić.
L’Associazione degli Artisti di Prijedor ha istituito un premio chiamato Premio Internazionale Annuale “Paola de Maninkor” per il miglior murale di Prijedor. È un’artista trentina che ha realizzato il primo murale a Prijedor nel 1998 sulla Scuola elettrotecnica e meccanica di Prijedor insieme ai ragazzi dei Centri per profughi.
Portali: kozarski.com e prijedordanas.com
Link:
Inaugurare ottavo murales a Prijedor – Premio internazionale Paola de Manincor.
COMPUTER PORTATILI PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL’OBBLIGO E SUPERIORI
Questa settimana, presso l’amfiteatro del Centro scolstico di Prijedor, sono stati consegnati 25 computer portatili ai rappresentanti delle scuole dell’obbligo e scuole superiori di Prijedor, destinati agli studenti che non possono acquistarli e che ne hanno bisogno per le lezioni online. I portatili sono stati finanziati dal Comune di Trento e cofinanziati dal Comune di Prijedor.
Si tratta del progetto “Rafforzare la cooperazione tra le scuole di Prijedor e del Trentino e sostenere la qualità della didattica a distanza”. “La consegna di computer portatili alle scuole primarie e secondarie di Prijedor non ha come obiettivo solo di migliorare la qualità dello studio a distanza, ma anche di rafforzare la collaborazione tra istituti scolastici tra Prijedor e Trentino, ovvero soprattutto tra studenti”, ha affermato Ezio Pilati, presidente dell’Associazione “Progetto Prijedor”.
La gratitudine per questa donazione non è stata nascosta nelle scuole di Prijedor. La cooperazione tra Trento e Prijedor, come dicono, continuerà nel periodo successivo.
“Ogni donazione, soprattutto in senso tecnico e di attrezzature per le scuole, significa molto per noi. Siamo grati ai nostri partner dall’Italia per questo prezioso dono. Speriamo che questa cooperazione duri per anni”, ha affermato Aleksandar Miljesic, presidente del Comitato direttori delle scuole superiori di Prijedor.
L’acquisto di computer portatili è costato circa 16.000 KM, di cui la città di Trento ha stanziato più di 11.000 e la città di Prijedor circa 5.000 KM.
Grazie alla collaborazione pluriennale tra Trentino e Prijedor.